La promessa di sicurezza è una falsa promessa
Ha scritto Miguel Benasayag, psicoanalista e filosofo militante, che la “promessa di sicurezza è una falsa promessa”: chiede in cambio un po’ di libertà e genera l’opposto di ciò che lascia intravedere; genera regolarmente insicurezza. Che altro pensare dell’ennesimo pacchetto sicurezza governativo? Stavolta la firma in calce è di Giorgia Meloni e dei suoi ministri, ma lo schema non cambia, dal “pacchetto Prodi” in poi. (…)
Le inutili stragi, il cessate il fuoco
Un esemplare articolo di Mao Valpiana su Gaza, Israele, Hamas, i crimini di guerra e l’urgenza di un cessate il fuoco, tenendo fermo lo sguardo a un credibile futuro, che dovrà essere – necessariamente – di convivenza
di Mao Valpiana (presidente del Movimento nonviolento)
Le ragioni dei civili palestinesi restano tali, nonostante i crimini di Hamas. Le ragioni dei civili israeliani restano tali, nonostante i crimini del governo Netanyahu. Quando si bombarda o si lanciano missili, si passa immediatamente dalla parte del torto. I civili dell’una e dell’altra parte, sono dunque doppiamente vittime: del nemico e dei loro governanti (che entrambi hanno votato nell’illusione di avere maggior difesa e sicurezza).
I capi di Hamas, ideatori e responsabili della pianificazione dell’attacco al cuore di Israele del 7 ottobre, non sono a Gaza; vivono protetti nel Qatar, in Iran, in Libano. Sono generali che conoscevano benissimo la reazione di Israele, che avrebbe decuplicato il numero delle vittime subite. Quei generali considerano la povera gente di Gaza come carne da macello, da sacrificare “fino all’ultimo uomo” (misogeni come sono non considerano le donne nemmeno da morte). Hanno introdotto a Gaza carburante per il lancio dei missili, ma non per i generatori degli ospedali. Hanno introdotto tecnologia avanzata per ordigni, ma non taniche d’acqua potabile per la gente. Sono di fatto nemici del loro popolo. Mistificano la resistenza con il bisogno di martiri.
Mi hanno fatto venire in mente una vecchia canzone antimilitarista di Enzo Jannacci, “Il monumento”: “il nemico non è oltre la tua frontiera, non è al di là della tua trincea: il nemico mangia come noi, parla come
noi, ma è diverso da noi. Il nemico ruba il pane per fare altri cannoni, per un’altra guerra”. Il cinismo con il quale agiscono questi capi militari, che nascondono gli ostaggi tra la popolazione, rendendola un bersaglio sacrificale, richiama l’indifferenza di alcuni generali italiani per i loro soldati durante la Grande Guerra. Le truppe sbandate del Regio esercito italiano, in prevalenza poveri giovani operai e contadini analfabeti, dopo la disfatta di Caporetto si resero ben conto che la responsabilità della tragedia che stavano vivendo era da imputarsi non solo alla superiorità degli eserciti austro-ungarico e tedesco, ma soprattutto al cinismo e alla strategia dei “generali felloni” come Cadorna e Graziani, che li mandarono al massacro. “Cadornismo” fu il termine coniato da Gramsci per definire “l’abitudine criminale di trascurare di evitare sacrifici inutili”. Cadorna ieri, e Hamas oggi, dice Gramsci, “hanno mostrato di non tenere conto del sacrificio altrui e hanno giocato con la pelle altrui”. Il nemico più pericoloso è il nemico vicino, interno: i carabinieri che sparavano alle spalle dei disertori, i terroristi di Hamas che impediscono ai civili di lasciare le loro case che sono nel mirino degli israeliani.
Allo stesso modo i civili di Israele, i familiari degli ostaggi, hanno come primo nemico il loro fronte politico interno, che li rende vittime designate dell’odio delle migliaia di terroristi che si stanno formando tra le macerie di Gaza. Dirò poche parole su quanto stanno facendo le forze armate israeliane, di terra e dell’aviazione, nella striscia di Gaza, perché è sotto gli occhi di tutti. Per mirare a distruggere i centri operativi di Hamas, si sta colpendo indiscriminatamente la popolazione civile: le migliaia di civili morti, in prevalenza bambini e donne, sono considerati “effetti collaterali”, ma sono veri e propri crimini di guerra. È il “terrorismo aereo”, per fiaccare il morale della popolazione civile (già collaudato storicamente da Stati Uniti e Regno Unito a Dresda, attuato poi dalla Russia con la distruzione completa di Groznyj nella prima guerra cecena o ad Aleppo nella guerra siriana). I civili sono il vero obiettivo dei bombardamenti a tappeto.
Ci vorrà un tribunale speciale per capire fino in fondo l’entità della strage in atto e condannare tutti i responsabili. Il governo di Netanyahu ha trasformato la legittima difesa in vendetta, la giustizia in rappresaglia. Israele aveva molte ragioni dopo l’attacco terroristico subito il 7 ottobre, davvero “senza precedenti”, ed ora ha anche molti torti, troppi torti. La richiesta che viene dalle due popolazioni civili, “Cessate il fuoco”, è l’imperativo che anche l’Onu e il Papa, e il movimento pacifista mondiale, hanno come priorità assoluta.
Per questo le manifestazioni per la pace non possono essere a senso unico: devono condannare i nemici interni della Palestina e di Israele, sostenere i diritti dei due popoli, piangere le vittime delle due parti, sostenere i gruppi misti che prefigurano la convivenza necessaria e desiderabile
Può capitare, specie a chi lavora nei media (ma forse è un sentimento diffuso), di sentirsi a disagio a confrontare il contenuto, il tono, i modi dell’informazione prevalente (diciamo pure dominante) con i discorsi che capita di intavolare nella propria cerchia di contatti e di amicizie, mi riferisco a persone informate, consapevoli, mediamente coscienziose. Quanto la grande informazione appare ripetitiva, prevedibile, quasi sempre in sospetta sintonia (salvo innocue sfumature) con i poteri del momento, tanto il discorso fra “informati dei fatti” è pluralistico, aperto al dubbio e cosciente della propria incompiutezza. Il disagio diventa allarme in casi critici come le guerre: prima con l’Ucraina, oggi con Israele e Gaza, la distanza – la frattura – fra i media e i cittadini mediamente colti e informati appare tanto netta quanto inquietante.
All’orrore e all’angoscia suscitati dai crimini di Hamas, è seguita nei media italiani un’ondata di giusta indignazione ma anche un’allarmante attitudine a rifiutare un dibattito il più ampio e il più lucido possibile su quanto avvenuto, sulle origini del terrorismo di Hamas, sulle condizioni di (non) vita del popolo palestinese, sui perché della deriva suprematista della politica israeliana, sulle possibili conseguenze dell’annunciata e in parte già praticata reazione militare israeliana in quella specie di inferno in terra che è la Striscia di Gaza.

Ha prevalso, nei media italiani, com’era avvenuto con l’Ucraina, e forse stavolta con maggiore ardore, una logica di immediato schieramento: Israele è stato aggredito, deve reagire militarmente e questo è tutto. Guai ad allargare il discorso alla storia del Vicino Oriente e alle varie fasi del conflitto fra Israele e i palestinesi; guai a domandarsi se l’estrema destra israeliana con le sue provocazioni abbia favorito l’ulteriore radicalizzazione di Hamas; guai a suggerire moderazione, a chiedere il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto da parte di Israele; guai a respingere il ciclo della violenza che chiama altra violenza e invocare una soluzione politica e intanto un intervento internazionale di pacificazione che porti a un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, all’apertura di una stagione nuova. Guai a dire che senza il rispetto dei diritti del popolo palestinese non c’è futuro per nessuno, nemmeno per la democrazia israeliana, già oggi ridotta a un regime di apartheid, come sostengono le maggiori organizzazioni (anche israeliane) di tutela dei diritti umani; guai a rifiutare di schierarsi per l’immediata e “risolutiva” reazione armata e guai a sentirsi vicini ai due popoli, l’israeliano e il palestinese, al dolore dei parenti di chi ha perso e sta perdendo la vita, e guai ad auspicare che in seno alle rispettive società civili nasca un movimento di lotta e rivendicazione nonviolenta di una via d’uscita, con spirito di fratellanza e convivenza, nel rifiuto dei fondamentalismi. Guai, insomma, a tutto ciò di cui si parla fra le persone mediamente colte e informate.
Nei talk show, negli editoriali dei maggiori quotidiani, negli interventi dei politici più in vista, con modeste eccezioni, prevale una logica manichea, quindi sostegno spasmodico alla risposta militare al terrorismo, evocazione di un presunto scontro di civiltà, rifiuto di ogni sforzo di comprensione contestualizzata dei fatti, tacciata, questa, di ambiguità se non intelligenza con il “nemico”. Leggere i maggiori quotidiani e ascoltare i più noti talk show per credere.
L’anatema per i “dissidenti” da questa “visione” è ricorrente, la ricerca di supposti complici occulti di Hamas un nuovo genere giornalistico, l’indifferenza per le posizioni espresse da chi opera in Israele e Palestina da decenni con spirito di fratellanza e desiderio di convivenza (decine di ong e associazioni, per non parlare del movimento pacifista e nonviolento) una regola non scritta. Il sistema dell’informazione, com’era accaduto dopo l’invasione russa dell’Ucraina, si è dimostrato incapace, o meglio non disponibile ad alimentare un dibattito serio, aperto, critico, il più possibile equilibrato su quanto accade in Israele e in Palestina e sulle scelte compiute e da compiere. Una crisi così profonda dell’informazione, lo sappiamo, non solo corrisponde a una crisi altrettanto profonda della democrazia stessa, ma contribuisce ad accentuarla.
Mai è stata così grande la distanza fra media e cittadinanza attiva, mai così vistosa la faziosità dell’informazione prevalente, mai così sconfortante la qualità del discorso pubblico. Mai così declinante la democrazia reale in occidente.
Israele, la flebile luce dell’azione nonviolenta
Una dozzina di anni fa, durante un viaggio in Israele e Cisgiordania, mi capitò di partecipare a un piccolo presidio nonviolento nei pressi di un villaggio palestinese nei territori occupati da Israele. Ci unimmo – eravamo in quattro – a un gruppetto di persone del posto che da qualche tempo manifestavano, con la propria presenza, per difendere i propri uliveti, minacciati d’essere estirpati. A una certa distanza, sulla collina opposta, si intravedevano militari israeliani e altre persone: osservavano, senza intervenire. Quel piccolo presidio, nell’economia di quel viaggio, fu uno dei pochi, forse l’unico, motivo di conforto, a fronte dell’angoscia suscitata dalla constatazione che un clima di oppressione e violenza gravava su tutta l’area. Angoscianti, in particolare, la condizioni di vita in Cisgiordania, che attraversammo fra posti di blocco, presidi militari, muri di separazione, strade semideserte. Ma angosciante, in modo diverso, anche la vita in Israele, una società di fatto militarizzata.
Si aveva la sensazione fortissima, già allora, d’essere in un vicolo cieco, con gli oppressori da un lato, sempre più decisi a estendere il proprio arbitrario controllo su terre e corpi altrui, e gli oppressi dall’altro, soggiogati, infelici e senza strategie politiche di liberazione, dopo il fallimento degli accordi di Oslo e la tragica stagione degli attentati. La via dell’azione nonviolenta, quindi la crescita dal basso di una nuova capacità di rivendicare i propri diritti, pareva un raggio di luce, sia pur flebile, in quella notte politica: prefigurava la possibilità di sbloccare lo stallo facendo leva sugli attivisti non militarizzati delle due parti e da lì cominciare a mobilitare le rispettive opinioni pubbliche. In quello stesso periodo Luisa Morgantini, con AssoPacePalestina, invitò in Italia un attivista nonviolento palestinese, che venne a raccontare le idee e le azioni di quel piccolo ma promettente movimento.

Sono passati oltre dieci anni e quel raggio di luce, a quanto pare, si è spento, o forse è stato spento. Lo Stato di Israele, da allora, ha addirittura accresciuto la propria pressione sulla popolazione palestinese, fra violenze, omicidi, nuovi insediamenti coloniali, fino a stabilire un sistema di potere che le maggiori organizzazioni internazionali (anche israeliane) per la tutela dei diritti umani definiscono di apartheid. Di pari passo, c’è stato un progressivo spostamento a destra dell’asse politico, fino all’attuale governo, estremista e suprematista, guidato dal solito Netanyahu; l’opinione pubblica democratica e pacifista, un tempo significativa in Israele, è finita ai margini della scena, quasi eclissata. Sul lato palestinese, l’opzione nonviolenta non ha preso campo e la direzione politica – se ve ne è davvero una – è impressa, in Cisgiordania, dal corrotto e confuso apparato dell’Anp e a Gaza – quella terribile prigione a cielo aperto – dal movimento islamista Hamas, protagonista in queste ore di una spaventosa reazione armata all’oppressione.
Agli uni e agli altri, al governo israeliano e ad Hamas, dovremmo chiedere qual è la via d’uscita che intravedono a questa esplosione di violenza, ma lo sappiamo già: non c’è via d’uscita, se non uno stato di guerra permanente, col più forte che farà pagare alla controparte, per chissà quanto tempo, il prezzo delle violenze di questi giorni, gettando le premesse per ulteriori rancori, altre violenze, senza che mai si manifesti una soluzione civile di un conflitto che perdura da troppi lustri.
Quanti passi indietro, in questi anni. Che sconforto. Eppure, di fronte all’orrore di queste ore, per trovare una ragione di impegno, se non ancora di speranza, è necessario tornare lì, a quel presidio nonviolento, a quel movimento che prendeva corpo fra gli attivisti palestinesi e che aveva dei punti d’appoggio non solo all’estero ma anche nella società civile israeliana.
Non saranno le bombe e i guerriglieri di Hamas, e nemmeno i tank e gli aerei da combattimento di Israele, a portare pace, diritti, rispetto della dignità di ciascuno in quella terra oggi disperata. La via d’uscita, se un’uscita ci sarà, verrà da chi è oggi è silente ed emarginato, da chi vorrà investire tempo, energia, intelligenza nella costruzione dal basso di una visione nuova di convivenza: sono le persone che dobbiamo incoraggiare. Come dobbiamo chiedere, noi cittadini di paesi ancora (abbastanza) democratici, la ricostruzione di organismi sovranazionali efficienti e autorevoli, perché c’è il bisogno urgente di un cessate il fuoco immediato e del ripristino di condizioni di vita degne per la popolazione palestinese, vessata oltremisura dallo Stato israeliano e abbandonata al suo destino dalla comunità internazionale.
Difficile per noi europei, cittadini di paesi storicamente vicini allo Stato di Israele, non sentirci in qualche misura responsabili di quanto accadendo, per l’ignavia, la complicità, le tante viltà dei nostri Stati in questi anni; come non rimproverarci una parte di responsabilità per la deriva autoritaria di Israele e le sue sistematiche violazioni della legalità internazionale? E come non sentirci responsabili, in quanto cittadini attivi, per non avere sostenuto a sufficienza, con adeguata convinzione, la prospettiva nonviolenta coltivata nella società civile palestinese come in quella israeliana da illuminate minoranze attive?
Nelle notte profonda delle violenze e degli eccidi, si può forse uscire dalla sensazione di sgomento e di impotenza che ci affligge, riannodando questo filo, scommettendo sull’impegno di quelle minoranze che ancora oggi, nonostante tutto, vogliono credere di poter costruire un futuro di convivenza degno d’essere vissuto.
Ma il film di Garrone è consolatorio. Un’occasione mancata
“Io Capitano” può essere definito un bel film: per come è realizzato, per la qualità delle interpretazioni, per il pathos che trasmette e anche perché getta un fascio di luce su uno dei grandi scandali del nostro tempo, la scelta compiuta dalle democrazie europee di “lasciar morire” migliaia di persone ai propri confini. E tuttavia il film di Matteo Garrone non convince.
“Io Capitano” racconta l’avventura di due giovanissimi senegalesi lungo la rotta che attraverso il deserto porta alla Libia e poi all’Italia, e mostra le tragedie che vivono o almeno sfiorano, fra vessazioni, torture, vite perdute e abbandonate; eppure alla fine si esce dal cinema sollevati. Sollevati perché alla fine i “nostri eroi” ce la fanno e perché l’Italia vi compare come terra promessa; dunque un “bel film” che mostra alcune brutture ma non scuote e non turba più di tanto. Un film consolatorio.

I “cattivi” del film sono i trafficanti che affittano auto, pullman, barche a prezzi esorbitanti, e poi i poliziotti e i miliziani che picchiano, umiliano, torturano ed estorcono denaro, ma “Io Capitano” non mette a fuoco il nodo politico della questione e anzi rischia – involontariamente – di legittimare la falsa narrazione sulla “tratta dei migranti”, cioè l’idea che gli “scafisti” e i “trafficanti” siano i responsabili degli “sbarchi” e della presunta “invasione”, insomma la retorica politico-mediatica prevalente.
Matteo Garrone, in verità, è personalmente lontano da questa rappresentazione e nelle interviste sostiene la necessità di istituire canali di ingresso legale in Europa per tutti, ma il suo film manca di mettere a fuoco questo punto e quindi non affonda il colpo. “Io Capitano” resta quindi privo di spessore politico, omette di denunciare i veri responsabili del “sistema” che semina ingiustizia e morte, fra i quali ci siamo anche noi spettatori, in quanto cittadini di paesi che di fatto sostengono quel “sistema”.
Il regista ha precisato che il suo intento era semplicemente raccontare una storia mettendosi nell’ottica degli “altri”, cioè i ragazzi in viaggio verso l’Europa, e questo ha fatto, ma intanto “Io Capitano” può essere giudicato “un bel film” da chiunque, anche da chi finge di non sapere che il deserto nordafricano e il mare Mediterraneo sono diventati dei grandi cimiteri a cielo aperto per “nostra” scelta. Sono le democrazie europee, con le loro “politiche sull’immigrazione”, come sono ipocritamente chiamate, a sostenere i trafficanti, gli scafisti, le milizie che lucrano sulle “vite di scarto” che devono rimanere fuori dai
confini dell’Unione.
“Io Capitano” può anche essere definito un bel film, ma è certamente un’occasione mancata.
Siamo tutti e tutte figli e figlie di Pinochet
Giusto cinquant’anni fa – l’undici settembre 1973 – il colpo di stato dei militari cileni, guidati dal generale Augusto Pinochet e sostenuti dagli Stati Uniti, avviava una fase nuova non solo per il Cile, ma per tutto l’occidente (e non solo). Nel paese sudamericano si instaurò una feroce dittatura destinata a durante quasi vent’anni, ma cominciò anche una stagione di esperimenti economici di grande successo per chi li promuoveva, per quanto nefasti sotto molti altri punti di vista.
È noto che sotto l’egida di Pinochet, ebbe mano libera nella società cilena la cosiddetta Scuola di Chicago, un gruppo di temerari economisti, capitanati da Milton Friedman, sostenitori di una teoria economica fin lì considerata del tutto marginale, per i suoi irrealistici presupposti. Il dittatore affidò loro la “riforma” dell’economia cilena, cominciando con lo smantellamento delle minime strutture pubbliche, definite con orrore “socialiste”, introdotte dal governo di Salvador Allende nel poco tempo avuto a disposizione. La Scuola di Chicago, com’è noto, teorizzava la necessità di lasciare libero sfogo alle forze di mercato, agli “spiriti animali” del capitalismo; il mercato, diceva, è capace di autoregolarsi e garantisce la migliore allocazione possibile delle risorse. Non si curavano, quegli economisti, dell’esperienza accumulata sulle tendenze mono e oligopolistiche del capitale, né del sovrasfruttamento delle risorse e tanto meno delle disuguaglianze sociali, che anzi consideravano fenomeno naturale nonché carburante della dinamica sociale.
All’atto pratico, più che di smantellare lo stato, si trattò di privatizzare tutto il privatizzabile – infrastrutture, servizi sociali e sanitari, miniere e così via – e di affidare ai poteri pubblici il compito di favorire la libera intrapresa, abbattendo vincoli e limiti di qualsivoglia natura, riducendo le imposte, tagliando la spesa pubblica. È una storia che conosciamo bene, perché dal Cile si è estesa ben presto a tutto l’occidente, trovando un decisivo sostegno politico negli Stati Uniti di Ronald Reagan e nella Gran Bretagna di Margaret Thatcher.
È la storia, insomma, dell’era detta neoliberista del capitalismo globale, tuttora dominante in larga parte del pianeta. L’esperimento cileno, per le destre economiche e politiche di tutto il mondo, fu entusiasmante: il Pil ebbe una duratura impennata, l’uso (altri direbbero l’estrazione) di risorse naturali fu reso molto più efficiente, la classe medio-alta accrebbe notevolmente il proprio reddito e il proprio ruolo sociale e di potere; in aggiunta, l’ordine regnava nel Paese. Il Cile fece dunque scuola. Letteralmente, visto che da allora la vulgata neoliberista – cioè il privato meglio del pubblico; le privatizzazioni e le liberalizzazioni come compito dello stato; il taglio delle imposte sugli alti redditi; la riduzione della spesa pubblica; l’ideologia della crescita infinita – è diventata, da marginale teoria quale era, “la” teoria insegnata nelle facoltà di economia e fatta propria dalle maggiori forze politiche occidentali, visto che il fascino delle parole d’ordine neoliberiste conquistò a partire dagli anni Novanta anche le più importanti formazioni di sinistra, le quali a quel punto smisero – di fatto – d’essere tali, diventando partecipi del “pensiero unico” scaturito dalle visioni della Scuola di Chicago.
A distanza di cinquant’anni, è dunque giusto ricordare il golpe cileno anche in questa chiave globale. La presa del pensiero neoliberista è ancora forte in tutto l’occidente, nonostante i guasti e i disastri che ha prodotto, in termini di eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, di imbarbarimento delle disuguaglianze fra Nord e Sud del mondo e all’interno dei singoli paesi, di propensione a generare guerre per l’accaparramento di materie prime. In termini, anche, di incapacità di affrontare le emergenze del presente e del futuro: dalla catastrofe climatica alle sempre più gravi crisi geopolitiche. La vicenda del Cile ha anche dimostrato, contraddicendo un asse portante della vulgata (l’idea che il dominio del mercato garantisce democrazia), che la pratica neoliberista può ben accompagnarsi a regimi autoritari. Un fatto che dovrebbe inquietarci.
La dottrina avviata da Milton Friedman, e poi aggiornata da innumerevoli economisti e think tank, è oggi inservibile. Il nucleo fondamentale delle sue premesse logiche ha qualcosa di magico – la possibilità di una crescita infinita delle produzioni e dei consumi, la disponibilità illimitata di risorse naturali – e non offre appigli credibili per affrontare seriamente le emergenze ambientali, sociali e politiche del pianeta, se non in un’ottica di militarizzazione del ricco occidente e di mero contenimento, a vantaggio di un numero limitato di “salvati” e per un arco non prevedibile ma anch’esso limitato di tempo, delle prevedibili (e già in atto) conseguenze del collasso climatico.
Servirebbe un cambio di paradigma, quindi il rigetto – finalmente – della più grande eredità lasciata dal golpe cileno, ma tocca ammettere che tale prospettiva non sembra imminente, nonostante un nuovo pensiero economico, non più votato alla crescita e al profitto bensì alla giustizia sociale e alla tutela dei beni comuni, stia prendendo forma in varie parti del pianeta (anche, se non soprattutto, fuori dalla accademie). Intanto, per onestà, commemorando l’undici settembre 1973, dobbiamo riconoscere che tutti e tutte, nostro malgrado, siamo in qualche modo figli e figlie di Augusto Pinochet e del suo colpo di stato.
Lo ha detto Bebo dello Stato Sociale dal palco di piazza Alimonda, «pardon, piazza Carlo Giuliani» (come canta Alessio Lega in “Dall’ultima galleria”): «Dentro di noi, che eravamo adolescenti e non eravamo a Genova nel 2001, oggi risuona l’eco di giorni stupendi conclusi in modo terribile. C’è una cosa che la mia generazione ha preso da quei giorni: il lascito di fiducia in ciò che verrà domani; valgono ancora le parole: un altro mondo è possibile». È vero, erano giorni stupendi, perché Genova quell’estate accolse un movimento forte, creativo, profetico esteso tutt’attorno al pianeta; furono anche giorni terribili, perché sappiamo come finì, coi pestaggi, le torture, l’omicidio di Carlo, il rifiuto politico delle ragioni del movimento; un rifiuto rovinoso, che ha segnato un’epoca.
Nei nuovi libri di storia l’estate del 2001 è però liquidata in poche righe, per dire che negli anni del berlusconismo, fra tanti misfatti, ci fu anche quel tragico luglio di scontri, di torture e di morte; che uno strano movimento fece capolino e fu stroncato con la forza: una brevissima stagione già dimenticata.
È una rimozione che sfida la storia e anche il presente. Perché torni a Genova, pensi al 2001 e appena sollevi lo sguardo ecco la guerra in Ucraina e il riarmo del mondo, ecco l’Europa dei muri e del «lasciar morire» nel Mediterraneo, ecco gli eventi estremi e il collasso del clima, ecco il ritorno dei nazionalismi e l’avvento delle destre estreme come forze di governo. Pensi al 2001 e sai che un altro mondo era possibile. Quel movimento portò a Genova – via Seattle e Porto Alegre – una nuova lettura del mondo e disse che il pensiero unico neoliberista avrebbe portato il pianeta alla rovina, di guerra in guerra; guerre per l’accesso all’acqua e alle terre rare; guerre contro le migrazioni; guerre ai Sud del mondo; guerre di dominio. Un altro mondo era possibile, con nuove parole d’ordine: senso del limite in economia; cooperazione nei rapporti fra stati; giustizia ecologica (oggi diremmo climatica) per il pianeta…
Potremmo indicare le rovine del presente e dire: avevamo ragione noi. Ma non servirebbe a niente, perché contano i rapporti di forza e la storia non si riscrive a tavolino. Possiamo però rifiutare la rimozione e dire che l’estate del 2001 è stata un momento di verità. Si scontrarono allora due visioni del mondo e possiamo affermare, con l’esperienza di oltre vent’anni, che una visione era volta a «ciò che verrà domani» e anticipava i cupi scenari in arrivo per proporne di nuovi, attorno a «un’economia capace di futuro», come si diceva allora; l’altra visione era invece tutta calata nel presente, con la sua promessa di crescita infinita, di «globalizzazione» del benessere, di «pacificazione» sotto l’egida di un potere tecnocratico animato da una forma di pensiero magico, nel quale scompaiono i conflitti sociali, i limiti ecologici allo sviluppo, la complessità delle forme di vita sul pianeta Terra.
Lo scontro fu vinto, in apparenza, dai globalizzatori neoliberisti, dalla destra politica cui si unirono le maggiori forze di sinistra – o eredi della sinistra storica – che scelsero di cavalcare gli «spiriti animali» del nuovo capitalismo, con la fallace speranza di cavalcarli.
Ma quella vittoria è stata anche una sconfitta, perché niente è rimasto delle promesse di allora. Crescita infinita, benessere globale, pacificazione tecnocratica non sono più in agenda. La nuova promessa dei globalizzatori è piuttosto una minaccia e in molti casi una realtà già presente: è la prospettiva di una militarizzazione generale, con nuove forme di apartheid, il razionamento dei diritti e uno stato di guerra permanente. Il tutto mentre il mondo è in fiamme, come diceva Naomi Klein, qualche anno fa, in un libro che preconizzava la via di una necessaria rivoluzione per salvarsi dal collasso climatico, politico e sociale in corso.
Questa rivoluzione non è (ancora) all’ordine del giorno, ma resta necessaria, e quindi è giusto tornare al 2001 e riprendere il filo del discorso, sapendo che le ragioni di allora vivono nel presente, nelle mille lotte aperte, nelle disobbedienze di Ultima Generazione e nei piedi piagati dei migranti lavati a Trieste da Lorena e Gianandrea di Linea d’ombra; in una fabbrica in via di recupero cooperativo a Campi Bisenzio e nell’Alta felicità della Val di Susa… Le attuali classi dirigenti non sono all’altezza delle urgenze globali e non hanno un’idea credibile e decente di futuro, per cui occorre che gli attivisti, i pacifisti, i consapevoli, i non rassegnati, insomma che tutte le persone in movimento «si facciano classe dirigente», per dirla con le parole (e con i fatti) del Collettivo di fabbrica della ex Gkn, il cui canto – “E non c’è resa / non c’è rassegnazione / ma solo tanta rabbia / che cresce dentro me” – si è levato non per caso l’altro giorno in piazza Carlo Giuliani. Il «lascito di fiducia in ciò che verrà domani» non dev’essere disperso. Il filo non si è spezzato, la storia continua.
(uscito su Il Manifesto di domenica 23 luglio 2023)
Ex Gkn, verso una fabbrica “recuperata”
Dal notaio sono andati in quattordici, ma dietro di loro, al momento di mettere la propria firma in calce all’atto di costituzione della “proto cooperativa”, c’erano idealmente altre migliaia di persone, quelle che negli ultimi due anni hanno seguito e sostenuto la lunga lotta degli operai della Gkn, la fabbrica di semiassi chiusa con un colpo di Pec il 9 luglio 2021.
Lunedì 10 luglio è nato infatti l’embrione di Gff, la cooperativa che si propone di fare ciò che i fondi di investimento, gli imprenditori, gli enti pubblici hanno solo detto e forse finto di volere davvero: la re-industrializzazione dello stabilimento di Campi Bisenzio.
2 giugno, ma che c’è da festeggiare?
Inni, bandiere, sfilate militari, Frecce tricolori in cielo e grandi discorsi – su libertà, diritti, democrazia, costituzione – in volo sulle ali del vento. Il 2 giugno, festa della repubblica, è passato così, e così è stato celebrato a reti unificate su tutti i media, occupando stancamente la scena del discorso pubblico.
E però, nelle stesse ore, la cruda realtà dei fatti era lì a testimoniare quanto sia cresciuta la distanza fra i princìpi affermati nelle carte e richiamati nei discorsi ufficiali e la loro effettività. E’ accaduto, nelle stesse ore delle celebrazioni, che lo stato italiano si sia impegnato a fondo per scoraggiare e ostacolare gli interventi di soccorso da parte delle navi gestite da alcune ong e attive nel Mediterraneo vicino alle nostre coste. Si è imposto a un’imbarcazione – la Humanity 1 – di portare non già nel porto più vicino, bensì ad Ancora (quattro giorni di inutile navigazione in più), le trenta persone tratte in salvo da un gommone, e a due altre navi di soccorso – la Sea-Eye 4 e MareGo – è stato inflitto il fermo amministrativo per violazione del decreto Piantedosi, che disciplina, diciamo così, gli interventi di soccorso nel Mediterraneo.
Sono piccoli episodi, non nuovi, anzi ricorrenti e ormai di routine, ma il loro significato profondo non può sfuggire: la nostra democrazia, che afferma la preminenza dei diritti umani, che affonda le radici costituzionali nella garanzia di dignità della persona, la nostra democrazia che pure afferma in costituzione il diritto d’asilo, è una democrazia automenomata, ormai adagiata in uno stato di tale torpore da non riuscire nemmeno a guardare sé stessa con obiettività: altrimenti eviteremmo certi discorsi, certe celebrazioni.
Che democrazia è, che festa della repubblica dovremmo celebrare, se intorno a noi ci sono persone che lasciamo morire (che altro sono le politiche europee sull’immigrazione, se non una cinica strategia del “lasciar morire”?), se l’Europa cui partecipiamo e che abbiamo contribuito non solo a costruire ma anche a concepire (do you remember Ventotene?) è diventata una fortezza inespugnabile, circondata da muri che vengono difesi con ferocia, in un cimitero non solo di diritti e idealità, ma anche di persone, di corpi reali.
Dunque: che cosa festeggiamo davvero il 2 giugno? E il 25 aprile? Non dovremmo, invece, considerare queste ricorrenze come dei promemoria, delle giornate in cui riflettere pubblicamente su ciò che volevamo essere e ormai non siamo più?
Non abbiamo bisogno di celebrazioni, semmai di profonde, radicali trasformazioni.
Nei giorni scorsi – era il 25 aprile, Festa della Liberazione – a metà mattinata, nel pieno delle cerimonie, con canti, bandiere rosse e una certa commozione intorno, è arrivato sul cellulare il messaggio di amici in vacanza per qualche giorno in Croazia: «Stamani al bar» – scrivevano – «mentre facevamo colazione, abbiamo assistito all’arresto di un gruppo di migranti, davanti a noi in un grande prato; qualcuno ha provato a fuggire, ma i poliziotti li hanno inseguiti e presi. Tutti ragazzi giovani, rassegnati e con gli occhi spenti. Non riusciamo a toglierceli dalla mente. Ci è venuto da piangere, è stato bruttissimo». Davvero un bruttissimo modo, per questi amici, di celebrare il 78° anniversario della liberazione del nostro paese dal nazifascismo, ma un modo autentico e rivelatore.





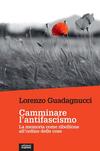 Camminare l'antifascismo
Camminare l'antifascismo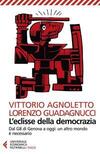 L'eclisse della democrazia
L'eclisse della democrazia Era un giorno qualsiasi
Era un giorno qualsiasi Restiamo animali
Restiamo animali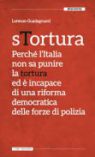 sTortura (scaricabile gratuitamente)
sTortura (scaricabile gratuitamente) Restiamo animali
Restiamo animali